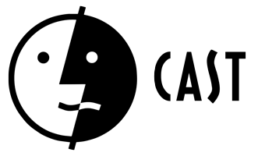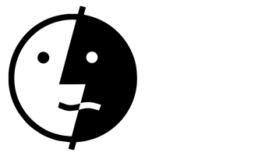Dato che il CAST accoglie un buon numero di persone giunte a noi dal circuito della migrazione, ci sembra importante mettervi al corrente delle modalità di funzionamento dell’accoglienza dei migranti in Italia.
Questo articolo di OPENPOLIS ci pare particolarmente chiaro ed esaustivo.
Dietro acronimi e numeri di richiedenti asilo, rifugiati e migranti si nascondono le storie di migliaia di persone. Vediamo come funziona il sistema dell’accoglienza in Italia, dall’arrivo all’integrazione.
Negli anni la normativa che disciplina l’accoglienza di richiedenti asilo, rifugiati e migranti in Italia è cambiata più volte.
A dicembre 2020 è stato convertito in legge il decreto legge 130 approvato due mesi prima dal governo Conte II, che contiene “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”. È un provvedimento che riforma in parte il cosiddetto decreto sicurezza, approvato circa due anni prima dal governo Conte I.
Anche il dl 130/2020, come il Decreto sicurezza, fa principalmente riferimento al dl.lgs 142/2015
Soccorso, prima assistenza e identificazione. I cittadini stranieri soccorsi in mare o entrati in modo irregolare sul territorio nazionale vengono condotti in centri governativi localizzati nei pressi delle aree di sbarco o di principale ingresso nel paese per la prima assistenza sanitaria, il fotosegnalamento e la pre-identificazione. Questo tipo di centri sono interessati dall’approccio hotspot, nato nel 2015 in ragione degli impegni assunti dal governo italiano con la Commissione europea. Nei centri avviene anche il primo scambio di informazioni sulle procedure per l’asilo: è qui che si differenziano i richiedenti asilo dai cosiddetti migranti economici, che saranno avviati ai Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) o lasciati sul territorio in condizione di soggiorno irregolare.
Centri governativi di prima accoglienza. Chi manifesta la volontà di richiedere asilo in Italia viene trasferito presso i Centri di prima accoglienza (Cpa), strutture di accoglienza di primo livello, dove si rimane il tempo necessario all’espletamento delle operazioni di identificazione (se non effettuate precedentemente) e all’avvio della procedura di esame della richiesta di asilo. In questi centri devono anche essere accertate le condizioni di salute degli ospiti, con il fine di verificare eventuali situazioni di vulnerabilità nel momento dell’ingresso nella seconda fase di accoglienza. Le persone che non hanno manifestato la volontà di chiedere asilo vengono invece trasferiti nei Cpr, in attesa del provvedimento esecutivo di espulsione dal paese.
La seconda accoglienza. Questo step consiste nel Sistema di accoglienza e integrazione (Sai). Il programma, introdotto con la riforma del 2020, sostituisce il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi), istituito con il Decreto sicurezza nel 2018, che a sua volta sostituiva il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), in vigore dal 2002 al 2018. Con il Sai si ritorna ai principi che avevano ispirato lo Sprar. Si tratta in un tipo di accoglienza meno puramente assistenziale e più volta all’integrazione. Al sistema possono accedere sia i richiedenti asilo che i titolari di protezione (coloro che hanno già visto accolta la richiesta di asilo e riconosciuto il diritto a una protezione internazionale). Il Sai si sviluppa su due livelli di servizi: il primo è riservato ai richiedenti asilo, ed è basato sull’assistenza materiale, legale, sanitaria e linguistica. I servizi di secondo livello sono riservati ai titolari di protezione e hanno anche funzioni di integrazione e orientamento lavorativo. A differenza della prima accoglienza, gestita a livello centrale, il Sai è coordinato dal Servizio centrale, la cui gestione è assegnata dal ministero dell’interno all’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) con il supporto operativo della fondazione Cittalia. Le titolarità dei progetti è assegnata agli enti locali che volontariamente attivano e realizzano progetti di accoglienza e integrazione.
Il supporto a percorsi di integrazione. Il dl 130/2020 introduce per la prima volta ulteriori percorsi di integrazione dopo la seconda accoglienza. Al termine del periodo nel Sai, infatti, le amministrazioni locali possono avviare altre iniziative con lo scopo di favorire l’autonomia individuale dei cittadini già beneficiari del Sai, con particolare riguardo a una maggiore formazione linguistica, all’orientamento lavorativo e ai servizi pubblici essenziali, e alla conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali sanciti dalla costituzione.
Il sistema di accoglienza straordinaria. Qualora si esaurissero i posti disponibili nei sistemi di prima e seconda accoglienza, le prefetture possono prevedere l’istituzione di Centri di accoglienza straordinaria (Cas) e affidarli a soggetti privati mediante le procedure di affidamento dei contratti pubblici. All’interno di questi centri vengono accolti i richiedenti asilo, limitatamente al tempo necessario al trasferimento nelle strutture del Sai. Nonostante si tratti di un sistema straordinario, l’utilizzo dei Cas (istituiti con il dl. lgs. 142/2015) è divenuto negli anni di gran lunga il maggioritario. Se infatti con la riforma del 2020 è previsto il trasferimento dalla prima accoglienza al Sai (previa disponibilità dei posti), il decreto sicurezza prevedeva il passaggio obbligato dei richiedenti asilo nei Cas.
Analisi
La riforma del 2020 ha disegnato un sistema di accoglienza con caratteristiche molto più simili a quelle che aveva fino al 2018, prima dell’approvazione dei decreti sicurezza voluti dall’allora ministro dell’interno Matteo Salvini. Il ritorno della possibilità di accedere alla seconda accoglienza anche per i richiedenti asilo (e non solo per i già titolari di protezione) e il passaggio del richiedente asilo dal sistema straordinario al Sai sono tra le disposizioni che danno la misura del cambio di indirizzo politico, rispetto al passato. Inoltre decreto sicurezza aveva fatto dei Cas un passaggio obbligato per i richiedenti asilo, aspetto appunto abolito dalla nuova riforma. Tuttavia, la divisione del Sai in due livelli preclude ai richiedenti asilo alcuni servizi volti all’integrazione. La seconda accoglienza, pur essendo orientata verso una maggiore integrazione e inclusione delle persone nel tessuto sociale, continua ad essere inoltre ampiamente sottoutilizzata dalle amministrazioni locali, e per questo sottodimensionata rispetto alle necessità. Con i due livelli, i richiedenti asilo che vengono accolti nei Cas, perché non ci sono posti disponibili nel Sai, potrebbero non godere degli stessi servizi dei richiedenti accolti nel Sai. Su questo sarà necessario capire come saranno strutturati i capitolati di gara che regolamentano nel dettaglio gli affidamenti per la gestione dei centri. Al gennaio 2021, infatti, non è ancora del tutto chiara l’applicazione della nuova riforma del sistema, approvata l’anno precedente.
Il CAST si posiziona nel sistema della Seconda Accoglienza: ospita persone che hanno vissuto questo percorso e crea progetti personalizzati per cercare di ridare ai suoi ospiti l’opportunità di divenire autonomi e di reinserirsi nella società e riprendere in mano la propria vita. Queste azioni sono possibili anche grazie al progetto “Siamo tutti noi” finanziato da “OTTO PER MILLE CHIESA VALDESE”.